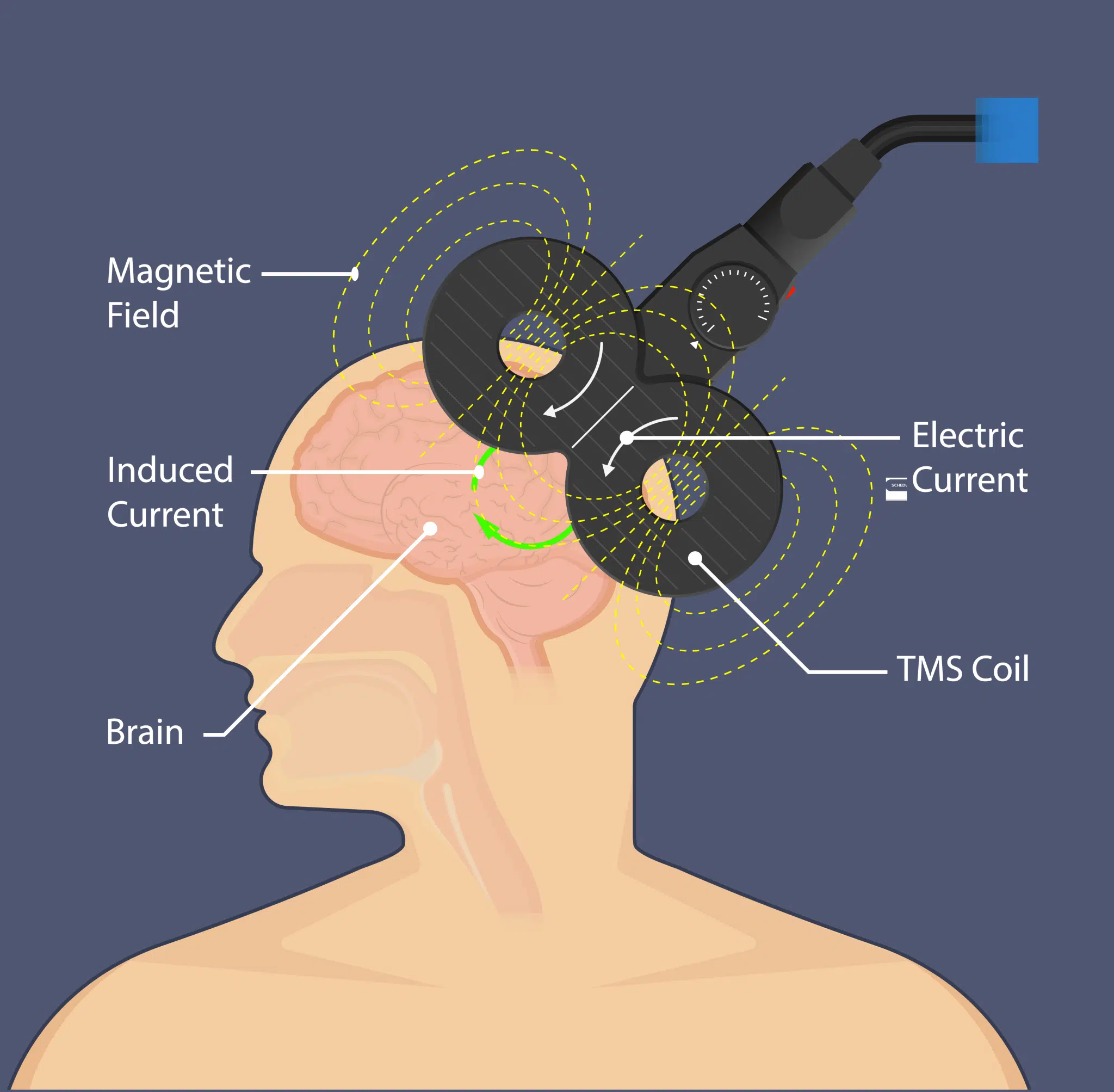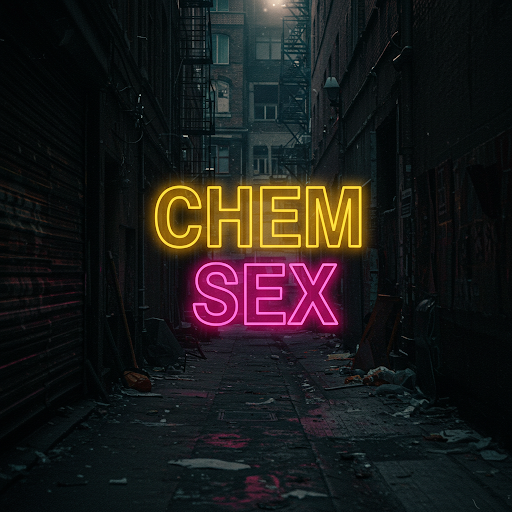Le dipendenze patologiche e i disturbi di personalità rappresentano due aree di sofferenza psichica significative e che spesso si presentano in concomitanza. Affrontare un percorso riabilitativo per la cura di una dipendenza senza considerare la possibile presenza di un disturbo di personalità in comorbidità comporta una alto tasso di ricadute, una difficoltà nella motivazione alla cura da parte ed una tendenza alla cronicità della dipendenza stessa. Comprendere la loro complessa interazione è fondamentale per un approccio clinico efficace e per favorire un percorso di guarigione stabile e duraturo.
Cosa è un Disturbo di Personalità?
Il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) definisce un disturbo di personalità come un pattern persistente di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o compromissione in almeno due delle seguenti aree:
- Cognizione: modi di percepire e interpretare sé stessi, gli altri e gli eventi.
- Affettività: gamma, intensità, labilità e adeguatezza della risposta emotiva.
- Funzionamento interpersonale: modalità di relazionarsi con gli altri.
- Controllo degli impulsi: capacità di gestire e modulare i propri impulsi.
Il DSM-5 raggruppa i disturbi di personalità in tre cluster principali (A, B e C), basati su somiglianze descrittive. È fondamentale sottolineare che la diagnosi di un disturbo di personalità richiede una valutazione clinica approfondita che tenga conto della storia individuale, dell’osservazione del comportamento e dell’utilizzo di strumenti diagnostici standardizzati. La comorbiità tra dipendenze patologiche e disturbi di personalità è descritta da numerose ricerche, che evidenziano una maggiore predisposizione allo sviluppo di dipendenze in individui con disturbi di personalità appartenenti al Cluster B (antisociale, borderline, istrionico, narcisistico) e al Cluster C (evitante, dipendente, ossessivo-compulsivo).
Le Dipendenze ed i Disturbi di Personalità si influenzano a vicenda.
- Vulnerabilità: i tratti di personalità disfunzionali possono aumentare la probabilità di iniziare e mantenere comportamenti di dipendenza. Ad esempio, l’impulsività e la ricerca di sensazioni tipiche del disturbo borderline o antisociale possono portare a sperimentare sostanze o comportamenti rischiosi. La difficoltà nella regolazione emotiva può spingere all’uso di sostanze come “automedicazione” per alleviare stati di ansia, depressione o vuoto interiore.
- Mantenimento: la dipendenza stessa può esacerbare i tratti di personalità disfunzionali. L’uso cronico di sostanze può compromettere ulteriormente la capacità di regolazione emotiva, le relazioni interpersonali e il controllo degli impulsi, alimentando un circolo vizioso.
- Fattori comuni: esistano fattori di rischio sottostanti comuni, come esperienze traumatiche precoci, predisposizione genetica e stili di attaccamento insicuri, che aumentano la vulnerabilità sia ai disturbi di personalità che alle dipendenze.
Un Approccio Integrato alla Cura
L’approccio clinico in presenza di co-occorrenza di disturbo di personalità e dipendenza richiede una prospettiva integrata e complessa:
- Diagnosi Accurata e Differenziale: è cruciale effettuare una valutazione diagnostica completa e accurata per identificare sia il disturbo di personalità (o i tratti significativi) che la dipendenza
- Stabilizzazione e Gestione della Crisi: inizialmente, può essere necessario focalizzarsi sulla stabilizzazione del paziente, soprattutto in caso di intossicazione, astinenza o comportamenti autolesivi.
- Trattamento Sequenziale o Parallelo: tradizionalmente, si tendeva a trattare prima la dipendenza e poi successivamente il disturbo di personalità. Studi scientifici degli ultimi anni invece indicano come best practice l’approccio parallelo o integrato, in cui entrambi i disturbi vengono affrontati contemporaneamente.
- Farmacoterapia: può essere utile per gestire sintomi specifici come depressione, ansia o impulsività, spesso presenti in entrambi i disturbi. È fondamentale un monitoraggio attento per evitare abusi o dipendenze da farmaci.
- Interventi Psicoeducativi: al paziente e ai suoi familiari sulle dinamiche tra dipendenza e disturbo di personalità, può aumentare la consapevolezza e la compliance al trattamento.
- Supporto Sociale e Gruppi di Auto-Aiuto: specifici per la dipendenza o per i disturbi di personalità, può offrire un importante supporto emotivo e sociale.
Psicoterapia Terza Ondata per una Cura Integrata
Le Psicoterapie di Terza Ondata raprresentano una serie di approcci di tipo Cognitivo Comportamentale di ultima generazione che offrono risultati clinici incoraggianti approcci incoraggianti per una terapia integrata tra dipendenze e disturbi di personalità:
- Dialectical Behavior Therapy (DBT): originariamente sviluppata per il disturbo borderline, la DBT si concentra sull’insegnamento di abilità di regolazione emotiva, tolleranza della sofferenza, efficacia interpersonale e mindfulness. È particolarmente utile per i pazienti con elevata impulsività e difficoltà nella gestione delle emozioni, spesso presenti sia nei disturbi di personalità che nelle dipendenze.
- Acceptance and Commitment Therapy (ACT): l’ACT mira ad aiutare i pazienti ad accettare i propri pensieri ed emozioni difficili, impegnandosi al contempo in azioni guidate dai propri valori. Questo approccio può aiutare a ridurre la lotta contro le esperienze interne negative, che spesso alimentano la dipendenza come tentativo di evitarle.
- Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP): integra pratiche di mindfulness per aumentare la consapevolezza dei pensieri, delle emozioni e delle sensazioni corporee che precedono l’uso di sostanze o i comportamenti compulsivi, fornendo strumenti per interrompere il ciclo della ricaduta.
- Schema Therapy: Si concentra sull’identificazione e la modificazione degli “schemi maladattivi precoci”, pattern di pensiero, sentimento e comportamento che si sviluppano nell’infanzia e influenzano negativamente la vita adulta. Questo approccio può aiutare a comprendere le radici profonde sia del disturbo di personalità che della vulnerabilità alla dipendenza.
L’integrazione di questi approcci, adattata alle specifiche esigenze dell’individuo, può offrire un percorso terapeutico più completo ed efficace per affrontare la complessa interazione tra dipendenze patologiche e disturbi di personalità, aprendo la strada a una vita più piena e significativa.
Bibliografia
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Linehan, M. M. (2015). DBT skills training manual (2nd ed.). Guilford Press.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.
- Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors. Guilford Press.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. Guilford Press.
- Verheul, R. (2017). Borderline personality disorder: Recent advances in understanding and treatment. F1000Research, 6, 1958.
- Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications. Harvard Review of Psychiatry, 4(5), 231-244.
- Grant, B. F., Chou, S. P., Goldstein, R. B., Huang, B., Stinson, F. S., Saha, T. D., … & Pickering, R. P. (2016). Prevalence of DSM-5 substance use disorder in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions-III. JAMA Psychiatry, 73(9), 949-958.
- Trull, T. J., Jahng, S., Sher, K. J., Widiger, T. A., & Morse, J. Q. (2010). Alcohol use disorders and personality disorder: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(1), 1-18.